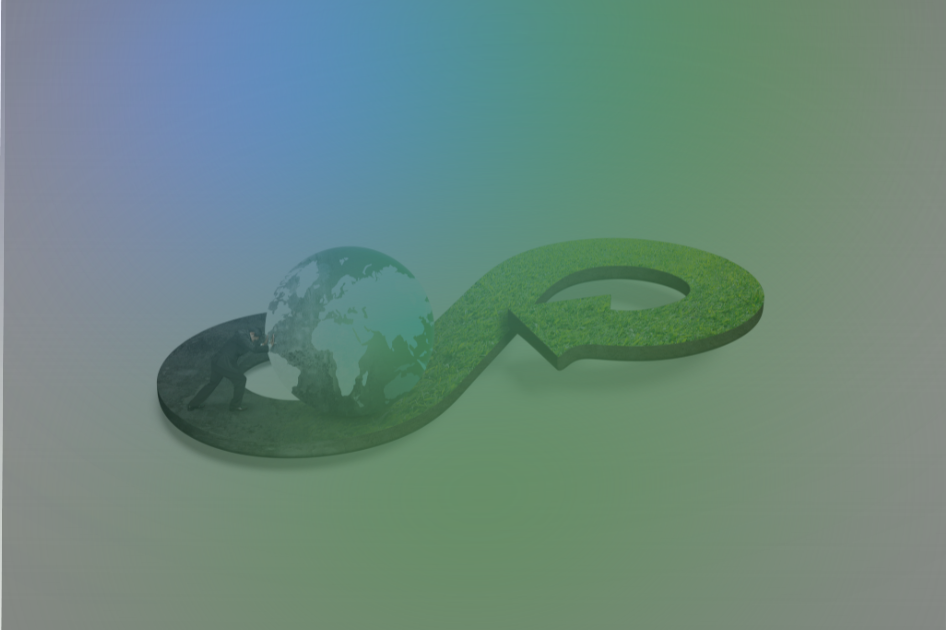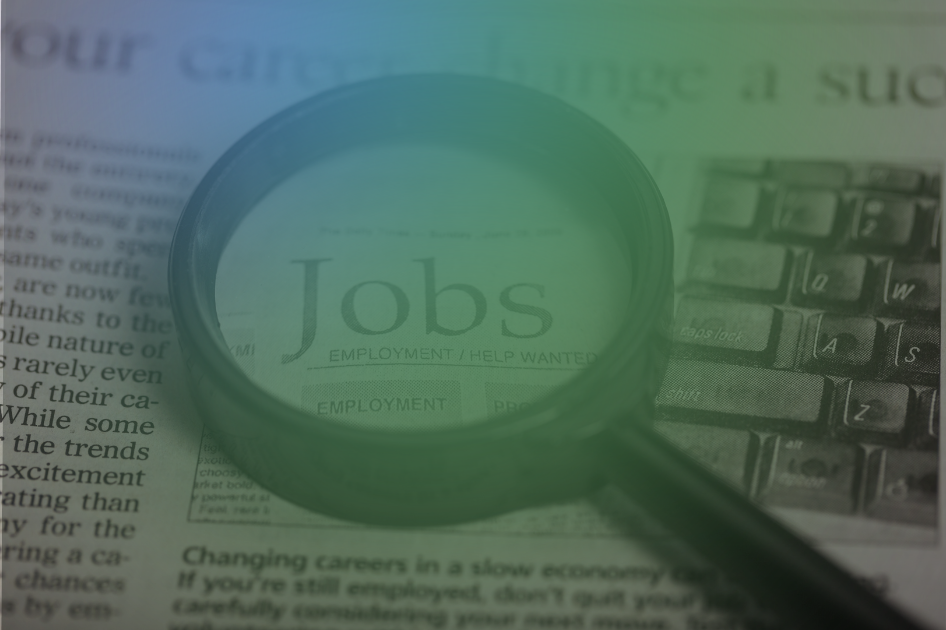In Europa si discute delle modifiche a CSRD, CSDDD e Tassonomia UE avanzate dalla Commissione Europea il 26 febbraio 2025, in occasione della presentazione dei primi due pacchetti Omnibus, che hanno riguardato tra l’altro anche il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Novità che, una volta definitivamente approvate anche dal Parlamento e dal Consiglio, entreranno in vigore dopo essere state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Se da un lato Bruxelles punta a ridurre gli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità, con l’obiettivo di stimolare la competitività delle imprese e liberare capacità di investimento aggiuntiva, dall’altro lato la proposta è stata accolta da pareri contrastanti nel mondo della politica e dell’economia.
Cosa sono CSRD, CSDDD e tassonomia UE
Emanata nell’ambito del Green Deal a dicembre 2022, la direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) introduce per numerose imprese l’obbligo di redigere l’annuale bilancio di sostenibilità, facendo riferimento, come parametro per la misura delle prestazioni, agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). In particolare la normativa, che in Italia è stata recepita il 30 agosto 2024 (Direttiva 2022/2464/UE), estende il dovere di reporting non strettamente finanziario a una serie di piccole e medie imprese europee (diverse dalle microimprese) quotate in borsa.
La CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), definita anche Supply Chain Act, richiede invece alle aziende di integrare attività di prevenzione e mitigazione degli impatti ambientali e sociali lungo l’intera catena del valore, dalla progettazione fino alla distribuzione e stoccaggio.
Infine, la Tassonomia UE è un insieme di criteri per la classificazione delle attività economiche in relazione a obiettivi ambientali, come uso sostenibile delle acque e delle risorse marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, difesa e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Cosa cambia con le modifiche del pacchetto Omnibus
Le modifiche alla CSRD consentiranno di esonerare circa l’80% delle imprese, posticipando di due anni (fino al 2028) gli obblighi di informativa per le realtà che attualmente sarebbero tenute a adeguarsi a partire dal 2026 o dal 2027.
Anche l’onere degli obblighi di informativa relativo alla tassonomia dell’UE verrà ridotto e limitato alle imprese di dimensioni maggiori (corrispondenti all'ambito di applicazione della CSDDD), mantenendo la possibilità di adesione su base volontaria per le altre aziende. Per diminuire ulteriormente costi e complessità a carico delle imprese, si limiterà poi la due diligence ai soli fornitori diretti (il cosiddetto Tier 1), si amplieranno gli intervalli di valutazione da 1 a 5 anni, si introdurrà un regime sanzionatorio più proporzionato e si posticiperà l’applicazione al 26 luglio 2028.
Secondo una stima prudenziale della Commissione UE, riducendo gli oneri amministrativi di almeno il 25% − e quelli per le PMI di almeno il 35% − entro la fine del mandato in corso, le aziende avranno risparmi complessivi in termini di costi amministrativi annuali di circa 6,3 miliardi di euro e mobiliteranno capacità aggiuntive di investimento pubblico e privato pari a 50 miliardi di euro a sostegno delle priorità politiche.

CSRD, semplificazione o deregulation? Il dibattito
Le modifiche, secondo la Commissione UE, rappresentano “un importante passo avanti nella creazione di un contesto imprenditoriale più favorevole per aiutare le imprese a crescere, innovare e creare posti di lavoro di qualità”, ma non mancano le posizioni critiche assunte da parte di rappresentanti politici, imprese e associazioni.
L’esecutivo UE viene accusato di penalizzare le aziende che si erano già allineate con le normative, rispettando la tempistica prevista, e di limitare l'accesso degli investitori a dati di sostenibilità comparabili e affidabili, compromettendo così la capacità di aumentare gli investimenti per la decarbonizzazione. Con buona probabilità molte aziende pubblicheranno in ogni caso report di sostenibilità a titolo volontario, non uniformi tra loro e privi di chiari riferimenti normativi. Questo scenario aumenterà confusione tra gli stakeholder, vanificando la comparabilità dei dati e compromettendo la rilevanza dell’informativa sulla sostenibilità nel suo complesso.
Questo caos potrebbe portare a una pericolosa deregulation. Ovunque si levano voci per uno stop almeno fino al 2040 come proposto dal blocco di estrema destra European Conservatives and Reformist Group, sfruttando la paura dei dazi americani, ribadendo che le norme del Green Deal indeboliranno il tessuto economico.
Sarà vero l’opposto: le norme green forniranno una barriera al commercio in Europa di quelle tecnologie e aziende che non rispettano la normativa, creando un piano di gioco certo complesso ma determinante, a patto che i 27 rimangano coesi sullo scacchiere mondiale.
Questo Blog è un progetto editoriale sviluppato da Ecomondo con Materia Rinnovabile
PUBBLICAZIONE
14/04/2025