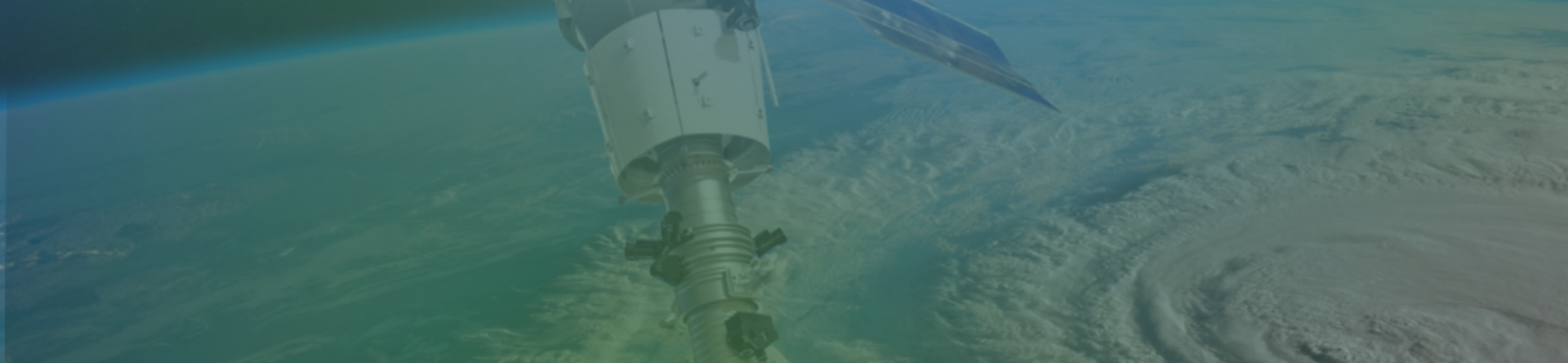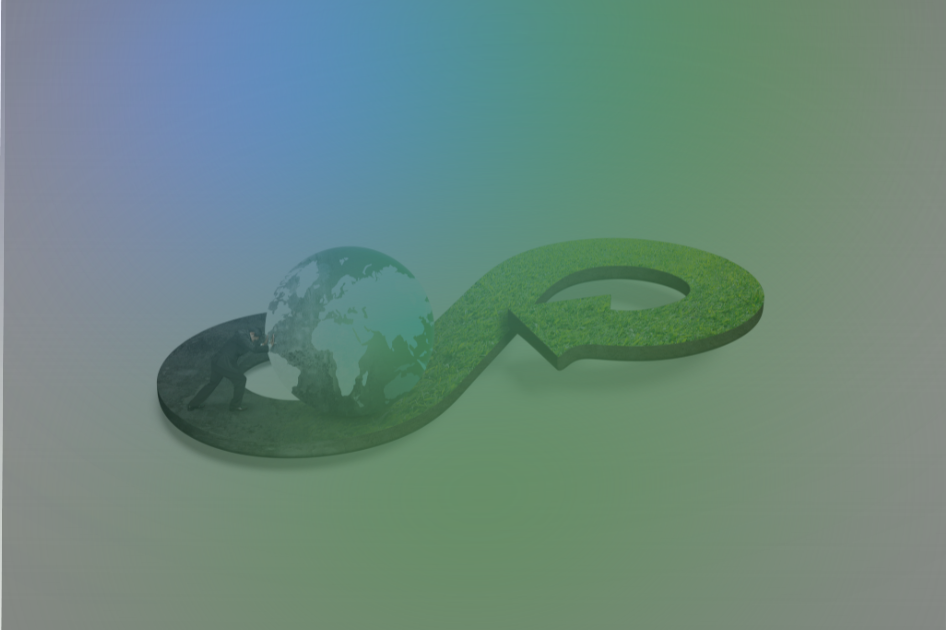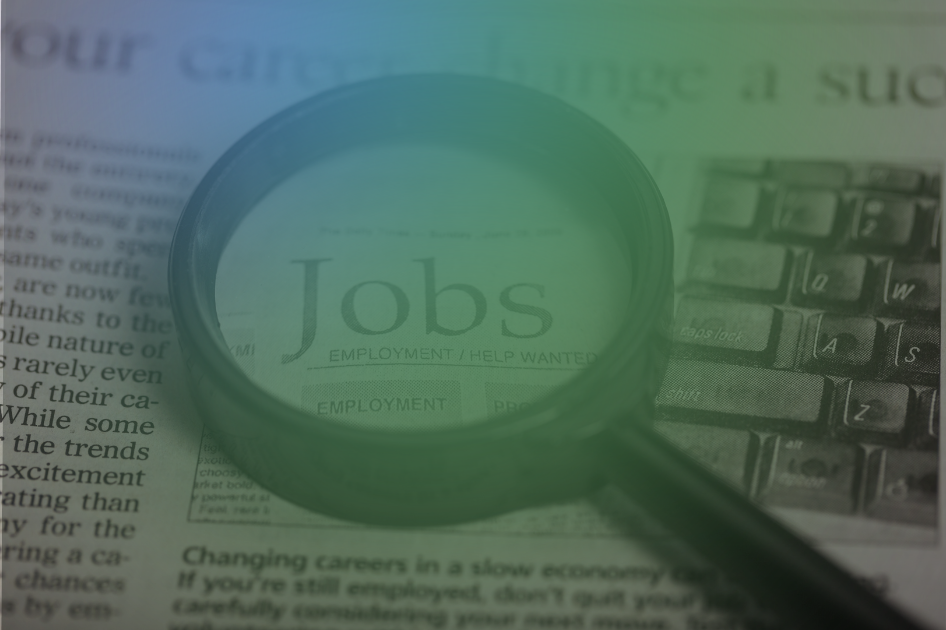Il problema dei rifiuti spaziali di satelliti e veicoli sta diventando sempre più pressante con l’aumento delle attività umane nello spazio. Fortunatamente, stazioni di riciclo orbitale potrebbero diventare presto realtà.
Nella notte del 21 agosto, accanto alle Perseidi, da Saronno, in provincia di Varese, alle 5.21 AM, si è potuto scorgere a occhio nudo il più grande oggetto umano nello spazio, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La Nasa ha reso disponibile un widget per poter individuare nella volta celeste questa struttura imponente, composta da moduli pressurizzati, tralicci strutturali, pannelli solari e altri componenti che sono stati assemblati in orbita nel corso di molteplici missioni di navette spaziali e razzi lanciati da vari paesi. Una delle più grandi collaborazioni intergovernative di sempre al di fuori del nostro pianeta.
Oggi questo goliath spaziale, lunghezza di circa 72,8 metri, larghezza di 108,5 metri (inclusi i pannelli solari) e una massa di circa 420 tonnellate, si avvia verso il suo fine vita.
Secondo la Nasa e l’Esa entro il 2030 la ISS sarà avviata a decommissioning, dopo due decenni di servizio ininterrotto. Il suo fine richiede però una pianificazione meticolosa, nel tentativo di recuperare più componenti possibili. Quando è stata realizzata, gli ingegneri non pensavano certo al suo fine vita, né a gestire moduli e componenti per il recupero. Oggi per il partenariato della ISS la principale opzione è il cosiddetto "controlled deorbit," che prevede di guidare la stazione verso un rientro sicuro nell'atmosfera terrestre. In questo scenario, la ISS verrebbe fatta rientrare in un'area remota dell'Oceano Pacifico, nota come "Point Nemo", per minimizzare i rischi di impatto con aree abitate. Si cercherebbe però di salvare così alcune costose componenti selezionate da riportare sulla terra.
Al momento la NASA si è impegnata con lo Smithsonian National Air and Space Museum e altre organizzazioni a sviluppare un piano di conservazione per alcuni oggetti della stazione spaziale. Più per commemorazione che per economia circolare, ma sicuramente si cercherà di traslocare quanti più oggetti possibile. Un’altra opzione, spiegano dalla Nasa, è il passaggio a un'orbita più alta. L’agenzia spaziale americana ha valutato la possibilità di spostare la ISS dall'orbita attuale a un regime orbitale più alto, dove la sua vita potrebbe essere teoricamente prolungata, preservando così la navicella per le generazioni future. La stazione spaziale attualmente opera ad un'altitudine (415 km dalla superficie) in cui l'atmosfera terrestre crea ancora resistenza e richiede un regolare rilancio per rimanere in orbita.
Un Universo di rifiuti

Oltre al decommissioning della ISS, il problema dei rifiuti spaziali di satelliti e veicoli sta diventando sempre più pressante con l’aumento delle attività umane nello spazio. Con oltre 34.000 oggetti di dimensioni superiori ai 10 cm in orbita, e centinaia di milioni di frammenti più piccoli, i detriti spaziali rappresentano una minaccia crescente sia per i satelliti operativi che per le future missioni spaziali nell’aria di orbita LEO (Low Earth Orbit, con un’altezza media di 800 km)
Per affrontare questo problema, la comunità scientifica e l'industria spaziale globale stanno sviluppando una serie di tecnologie innovative per la raccolta e il riciclo dei rifiuti spaziali. Queste tecnologie sono essenziali non solo per ridurre il rischio di collisioni, ma anche per promuovere un utilizzo più sostenibile delle risorse orbitali e proteggere la terra.
Nel marzo del 2022, una famiglia della città rurale di São Mateus do Sul, in Brasile, ha trovato un pezzo di metallo di 600 chilogrammi in frantumi a soli 50 metri dalla loro casa. Quattro mesi dopo, due allevatori di pecore australiani hanno trovato uno strano oggetto nero che sembrava essersi conficcato in un campo. E infine il 23 maggio 2024 un agricoltore di Ituna, Saskatchewan in Canada, ha rinvenuto un oggetto simile di vari quintali.
Tutti e tre appartenevano alla SpaceX di Elon Musk. Di fatto oggi la private company del magnate è uno dei principali produttori di “space junk”. Solo nel 2023, SpaceX ha tentato 98 dei 223 lanci orbitali del mondo, lasciandosi alle spalle un bel po' di roba. L'azienda inoltre ha attualmente in orbita 5.420 satelliti Starlink e prevede di aumentarne il numero a oltre 12.000 (ma si vocifera potrebbero arrivare oltre i 40mila) nei prossimi anni. I satelliti di SpaceX hanno una durata di vita stimata di cinque anni, il che significa che l'azienda dovrà inviare costantemente satelliti sostitutivi per mantenere la rete globale attiva. Per i critici, si tratta di un approccio incredibilmente dispendioso. "Plaudo a SpaceX per aver sviluppato razzi riutilizzabili", ha dichiarato a Wired USA Moriba Jah, professore di ingegneria aerospaziale dell'Università del Texas e intellettuale spaziale. "Ma non abbiamo satelliti riutilizzabili. Quello che lanciamo equivale a una plastica monouso".
Musk però ha un piano: usare le sue Starship per allocare tecnologie di raccolta di componenti e detriti. Ma al momento non ci sono informazioni dettagliate sul progetto.
La questione rimane in cima all’agenda di agenzie spaziali (Nasa, Esa, Isro) e organizzazioni aerospaziali come la Federal Aviation Administration, che ha stimato che dal 2035 circa 28,000 frammenti pericolosi, che sopravviveranno ogni anno alla combustione durante il rientro, ferendo o uccidendo una persona a terra ogni due anni.
Nel 2023 l’ESA, durante lo Space Summit di novembre ha lanciato lo Zero Debris Charter, un'iniziativa leader a livello mondiale che mira a rendere neutre le missioni future nello spazio entro il 2030. Ad oggi oltre 100 organizzazioni in tutto il mondo hanno dichiarato la loro intenzione di firmare e unirsi allo sforzo collaborativo nei prossimi mesi. "È fondamentale proteggere il futuro dei nostri beni spaziali più preziosi e cruciali mantenendo le orbite terrestri libere da detriti. Firmando congiuntamente la Carta Zero Debris, le diverse entità dimostrano una leadership globale nella mitigazione e nella bonifica dei detriti spaziali", ha affermato Josef Aschbacher, Direttore generale dell'ESA, durante l’evento di Siviglia.
Secondo Holger Krag, responsabile della sicurezza spaziale dell'ESA. "La comunità Zero Debris è impegnata a mettere mano agli standard e alle tecnologie di mitigazione dei detriti per rendere l'uso pulito e sostenibile dello spazio una realtà". L'approccio si baserà sulle tecnologie di mitigazione e bonifica dei detriti sviluppata dal Programma di sicurezza spaziale dell'ESA.
Tecnologie per la raccolta dei rifiuti spaziali
Se per i progettisti aerospaziali l’obiettivo è satelliti a rifiuti zero, bisogna in ogni caso ripulire la LEO dai frammenti in orbita. Una delle tecniche più promettenti per catturare i detriti spaziali è l'utilizzo di reti e arpioni. Questi strumenti possono essere lanciati da satelliti di servizio per agganciare e raccogliere i detriti. Le reti sono particolarmente utili per catturare oggetti di dimensioni irregolari, mentre gli arpioni possono perforare e trattenere detriti più solidi.
Un esempio è il progetto RemoveDEBRIS dell'Università del Surrey, sostenuta da un consorzio di compagnie, incluso il colosso Airbus, che ha già realizzato quattro test, l’ultimo nel 2023, impiegando un satellite sperimentale è stato progettato e costruito - ed è gestito in orbita - dalla filiale Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) di Airbus. Il veicolo spaziale è dotato di tre tecnologie Airbus per la rimozione attiva dei detriti: una rete e un arpione per catturare la spazzatura spaziale, nonché un sistema di navigazione basato sulla visione (VBN) per convalidare le tecniche di tracciamento dei detriti in orbita con telecamere e LIDAR. Al momento di pubblicare questo articolo la compagnia non ha risposto ad una richiesta dell’autore per capire quali saranno i futuri impieghi del sistema.
Anche l’ESA ha il suo progetto di satelliti spazzini, CleanSpace. Esso mira a sviluppare un satellite capace di rimuovere oggetti spaziali obsoleti e che, secondo un portavoce dell’agenzia, contattata dall’autore, vedrà il primo lancio nel 2026 per recuperare un satellite fuori uso, fermo nella low-earth orbit dal 2001.
Non mancano le start-up. Come Starfish Space, di Seattle, sostenuta da investitori tra cui Toyota Ventures, sta lavorando a una navicella per la rimozione dei satelliti e, dopo un tentativo fallito di aggancio con un satellite a metà del 2023, ci riproverà all'inizio del prossimo anno. Oppure ClearSpace, spin-off del centro spaziale svizzero EPFL, che sta sviluppando una soluzione simile, soprattutto per i detriti di piccole dimensioni. La startup prevede di rimuovere i primi detriti dallo spazio entro il 2025.
Un'altra tecnologia potenziale prevede l'uso di laser spaziali ad alta potenza per modificare la traiettoria dei detriti. Sparando brevi impulsi laser controllati da una AI contro i detriti, si può alterarne leggermente la velocità e la traiettoria, spingendoli verso un'orbita di decadimento. Questa tecnica, sviluppata dalla West Virginia University, ancora in fase sperimentale, potrebbe diventare una soluzione efficace per ridurre il numero di piccoli detriti in orbita.
"Il nostro obiettivo è sviluppare una rete di laser spaziali riconfigurabili, insieme a una serie di algoritmi", ha dichiarato in un comunicato Hang Woon Lee, direttore dello Space Systems Operations Research Laboratory dell’ateneo, che guida il progetto. "Questi algoritmi saranno la tecnologia abilitante che renderà possibile tale rete e ne massimizzerà i benefici". Combinata con i sistemi di raccolta potrebbe ottimizzare le traiettorie e i tempi degli spazzini spaziali.
Ricilo a 10mila chilometri di altezza
Oltre alla raccolta, il riciclo dei detriti spaziali rappresenta una sfida e un’opportunità significativa sul lungo termine, specie per lo sviluppo di una civiltà interplanetaria e un aumento considerevole dei viaggi spaziali, inclusi quelli turistici e di ricerca. Riciclare i rifiuti spaziali (e riciclare i rifiuti nello spazio, come già avviene sulla ISS) potrebbe trasformare un problema in una risorsa, riducendo la necessità di lanciare nuovi materiali dalla Terra.
Alcuni progetti stanno esplorando la possibilità di riciclare i materiali direttamente nello spazio. Ad esempio, i detriti metallici potrebbero essere raccolti e fusi per produrre nuove strutture o componenti satellitari direttamente in orbita. Questo approccio potrebbe ridurre i costi e la necessità di inviare nuove risorse dalla Terra. Per questo l’Esa ha un progetto sviluppato con la filiera industriale aerospaziale chiamato ‘On-Orbit Manufacture, Assembly and Recycling’ (OMAR), di fatto il primo programma integrale di economia circolare nello spazio.
In un futuro non troppo lontano, potremmo vedere la costruzione di stazioni di riciclo orbitali, dove i rifiuti spaziali verrebbero raccolti, smontati e trasformati in materiali utili. Queste stazioni potrebbero funzionare in modo simile a una moderna stazione di riciclaggio sulla Terra, con la differenza che opererebbero in microgravità. Altra opzione (fanta)scientifica e circolare, il riutilizzo dei satelliti obsoleti. Si ipotizza che sistemi orbitanti potranno riutilizzare satelliti ormai fuori servizio, impiegando componenti potrebbero essere riutilizzati per costruire nuovi satelliti o come materia prima per altri progetti spaziali, fuori dall’atmosfera terrestre. O sulle future basi spaziali sulla Luna, Marte o chissà dove.
Un articolo di Emanuele Bompan
PUBBLICAZIONE
30/08/2024